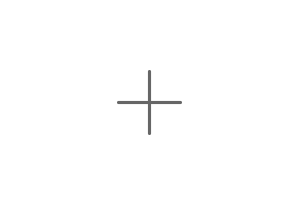La storia di Spoleto dalle origini al medioevo: il Ducato di Spoleto.
Per la felice posizione che occupa, sulla cima del colle S. Elia e ai piedi del Monte Luco che la proteggeva, l’area di Spoleto fu abitata fin dai tempi molto antichi. Resti di alcune abitazioni e parti di costruzioni megalitiche che formavano una primitiva cinta muraria, meglio note come Mura Ciclopiche, risalgono all’Età del Bronzo quando la zona era occupata dalla popolazione degli Umbri.
Spoleto interessò ben presto i Romani che cominciarono ad estendere il proprio dominio sulla città fin dal 241 a.C. facendone una colonia. Pochi decenni dopo, con la costruzione della Via Flaminia che attraversava la città da parte a parte (si entrava per Porta Monterone a sud e si usciva da Porta Fuga a nord), l’importanza della città crebbe ulteriormente. In occasione della seconda guerra punica gli Spoletini si distinsero per il valore con cui fermarono l’avanzata di Annibale verso Roma tanto da ottenere, nel 90 a.C., il prestigioso titolo di municipium. Per tutto il periodo dell’Impero, Spoletium dovette godere di grande fama e di ingenti ricchezze testimoniate dai numerosi resti romani ancora ben conservati in città. E questa condizione di privilegio e di forte egemonia non dovette venire meno nemmeno con la caduta dei romani e l’arrivo dei barbari.
I primi ad occupare Spoleto furono i Goti di Teodorico il Grande, che la presero nel 493. Pochi decenni più tardi, l’imperatore bizantino Giustiniano, nel tentativo di recuperare i territori già appartenuti all’Impero Romano d’Occidente, inviò in Italia il generale Belisario. Riuscì a strappare la città ai Goti nel 537 ma la perdette nuovamente nel 545. Sconfitti i Bizantini, il re Totila stabilì il proprio quartier generale proprio a Spoleto e riuscì a mantenerne il controllo fino al 552 quando venne definitivamente sconfitto da un altro generale bizantino, Narsete.
Già del IV secolo, Spoleto divenne sede episcopale sviluppando una forte gerarchia ecclesiastica dovuta alla posizione al confine con lo Stato Pontificio, che ne costituirà sempre un grandissimo punto di forza.
In seguito all’arrivo dei Longobardi in Italia Faroaldo istituì il Ducato di Spoleto che assieme a quello di Benevento costituiva la Longobardia Minor. Un territorio molto vasto, che arrivava fino alla Calabria, e di cui i Longobardi avevano pieno controllo. Sebbene sotto la giurisdizione longobarda, Spoleto ed i suoi duchi poterono conservare una certa autonomia proprio grazie alla vicinanza dello Stato Pontificio. La situazione si modificò in parte solo a partire dal 729, quando la città passò sotto il controllo del re Liutprando.
Il Ducato di Spoleto cadde nel 774, quando i Longobardi vennero duramente sconfitti dai Franchi, alleati del Papa, ed i territori del Ducato vennero inglobati nell’Impero Carolingio prima e nel Sacro Romano Impero poi.
La storia di Spoleto durante l’età comunale e il Rinascimento.
Nonostante l’annessione al Sacro Romano Impero, il dominio di Franchi e Carolingi non fu particolarmente gravoso per Spoleto che continuò a godere di potere ed autonomia fino al duro attacco di Federico Barbarossa, il quale, sceso in Italia per essere incoronato Imperatore dal Papa nel 1155, incendiò la città distruggendone buona parte.
Per diverso tempo il controllo della città e del suo territorio fu oggetto di disputa e scontri tra Impero e Papato, fino alla definitiva annessione di Spoleto allo Stato Pontificio, nel 1198.
In questo stesso periodo la città si era autonomamente costituita sotto forma di libero Comune. La nascita degli ordini mendicanti (Benedettini, Francescani, Domenicani, Agostiniani) e la loro diffusione presso il Monte Luco, contribuì alla crescita esponenziale degli edifici religiosi del centro storico e all’abbellimento ed arricchimento architettonico della città. L’intervento del Cardinale Albornoz nel XIV secolo, con la costruzione della Rocca, conferì ulteriore importanza a Spoleto che divenne uno degli avamposti del papa durante il periodo della cattività avignonese e contribuì a richiamare artisti e visitatori da tutta Europa, quali Filippo Lippi e Antonio da Sangallo il Giovane, che resero la città un florido centro culturale fino al Seicento.
La storia di Spoleto durante l’età moderna.
Tra alterne vicende e pur conservando sempre la propria storia di autonomia ed indipendenza, Spoleto rimase ancora formalmente sotto il controllo pontificio fino alla breve parentesi del Regno napoleonico. Infatti, tra il 1808 ed il 1815, la città venne proclamata capoluogo del dipartimento del Trasimeno (da Rieti a Perugia) per volere delle truppe francesi. Sconfitti gli invasori d’oltralpe, tuttavia la Chiesa riconquistò la città e ne guidò le sorti fino al 1860, anno dell’annessione di Spoleto al nascente Stato italiano.
Nel secondo dopo guerra la città conobbe un periodo di profonda crisi economica legato al calo di occupazione nel settore agricolo e presso le miniere di lignite, che provocò una forte spinta migratoria.
Il periodo di difficoltà, tuttavia, pose le basi per la rinascita in chiave moderna con l’istituzione di eventi, manifestazioni ed enti locali che sono oggi l’attrazione turistica di Spoleto ed anche la sua linfa vitale ed identitaria: nel 1947 fu fondato il Teatro Lirico Sperimentale, nel 1952 nacque il Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, nel 1958 si svolse la prima edizione del Festival dei Due Mondi, arrivando alla famosissima Mostra delle Sculture di Spoleto nell’edizione del 1962, che rimane ancora oggi un evento culturale unico in Italia!